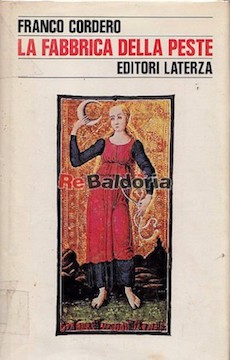
Nell’estate calda e umida dell’anno 1630 a Milano, ma anche a Pavia e Cremona, infuriava la peste. Dal 5 all’11 giugno i morti erano più di 100 al giorno. In luglio più di mille (all’inizio della epidemia secondo alcuni studiosi nella città vivevano circa centocinquantamila milanesi).
A Milano, città “bigotta salmodiante intronata nessuno si aspettava la peste e gli uomini savi e pii vedendo la violenza del morbo crescere a dismisura dopo aver invocato invano il celeste patrocinio lo dissero un castigo divino”. Quei pochi che pensavano che Dio nella tragica vicenda non c’entrasse per niente erano giudicati “teste storte” e quasi sempre erano perseguitati fino alla condanna a morte.
La medicina in mano a “terapeuti bestioni” del tutto simili a quelli descritti nel Malato immaginario di Molière, non poteva certo aiutare i milanesi.
Due personaggi – che Manzoni ha fatto rivivere nella sua Storia della colonna infame – giravano per le strade della città: i monatti rumorosi e gli untori furtivi.
Temuti ma indispensabili alla pulizia della città, i monatti percorrevano scampanellando e vociando giorno e notte le strade caricando cadaveri e moribondi prima accuratamente derubati e spogliati dagli abiti più ricchi. Così facendo contribuivano ad aumentare i contagi.
A far crescere il terrore ecco l’altro personaggio, l’untore (reale o immaginario) che si muoveva furtivo nell’ombra e mirava a scopi oscuri, fantasiosi e indecifrabili, ma agli occhi del popolo nutriva disegni sempre malvagi.
Era inevitabile che gli inquirenti mandassero a morte gli accusati scoperti quasi sempre per delazione e sottoposti a pesantissime torture “fabbricando tutti i colpevoli che volevano”. Anche perché gli untori possedevano una perfetta fisionomia sociale da imputato, svolgendo mestieri “infami come barbieri becchini e flebotomi”, attività tutte escluse dalle corporazioni.
In ambiente illuministico un secolo dopo, l’accanimento dei giudici sui presunti untori sembrerà inspiegabile. Pietro Verri non se ne capacita: ”il desiderio di uccidere gli uomini così a caso“ è per lui incomprensibile . Ma – osserva Cordero – “l’ottimismo illuministico non vale l’acume introspettivo cattolico” non arrivando a comprendere la situazione.
Va ricordato, infatti, che Milano era allora fra le città al top per numero di delitti e crimini della peggior specie, avvelenamenti, lotte a coltello e rapimenti.
Per combattere una situazione del genere la giustizia penale impotente e a sua volta corrotta inscenava ogni anno numerosi riti da Grand Guignol, forca ruota e squartamenti inflitti naturalmente a una plebe “rozza sudicia e ignorante”. Untori di classe sociale elevata si possono contare sulle dita di una mano.
Gian Giacomo Mora a Milano è il più famoso “untore“. Cordero narra la terribile vicenda come aveva fatto Manzoni nella sua Storia della colonna infame, passo a passo attraverso delazioni sospetti atrocità e torture fino alla condanna a morte, e con più acume e meno pregiudizi non gli risparmia critiche bollando le riflessioni manzoniane come tipiche di una “mente ottenebrata”.
Propongo qualche analogia con il nostro tempo: il posto dell’untore nella pandemia di oggi è preso da una figura dalla fisionomia indistinta, che sembra portare a compimento la vendetta della natura, provvista di un disegno occulto e terribile. Si direbbe che lo scopo sia quello di alleggerire o persino annullare la pressione della presenza dell’uomo colpevole e stupido distruttore del pianeta dove è nato.
Oppure dietro la pandemia più banalmente ci stanno i cinesi, sempre i soliti cinesi, potenti e lontani e per giunta poco trasparenti e da noi poco conosciuti? Lo pensano avversari bellicosi e invidiosi come Trump.
Come finisce la peste o le molte pesti che hanno colpito gli umani? Non sempre allo stesso modo: la peste del 1300, quella del Boccaccio e di Guglielmo d’Ockham, fu seguita da un secolo intellettualmente e artisticamente rigoglioso. Gli effetti del morbo “milanese” del Seicento sono più complicati e spiccano su uno sfondo movimentato. Appena prima dell’epidemia, Milano era andata crescendo in popolazione e ricchezza anche se non mancavano i conflitti fra le diverse attività industriali e mercantili ma a peste finita resistono soltanto i panettieri e una nuova mendicità dilaga.
La memoria della grande peste a noi più vicina, la “spagnola” del 1919 studiata magistralmente dal nostro Giorgio Cosmacini, catastrofe immane nella quale morirono soprattutto i giovani, è ancora oggi un problema: si direbbe che i ricordi siano come cancellati, soppressi.
Milano era ancora una piccola città ed è incredibile che quei cinquantamila morti siano stati rimossi. La mia bisnonna milanese che abitava al Cordusio perse quattro figli (i superstiti per fortuna ebbero lunga vita e non si ammalarono mai).
Tragedie simili sono state frequenti eppure…
Me lo spiego così: quel terribile morbo si è voluto dimenticarlo e persino cancellarlo dal passato familiare e collettivo.
Ma questo non è un buon segno: gli avvenimenti che seguirono immediatamente la tragedia (il ”ventennio”) consentivano o persino esigevano l’oblio.
Titolo: La fabbrica della peste
Autore: Franco Cordero
Editore: Laterza
Pagine: 450
Prezzo: 10,85 €
Anno di pubblicazione: 1985






