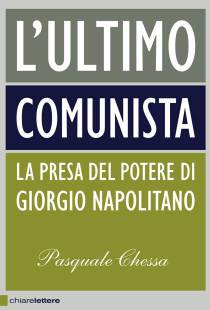
Un testo singolare, quello di Pasquale Chessa. E non tanto per quello che dice e che spiega. Ma piuttosto per quello che lascia capire senza spiegarlo. E per quello che non dice. Per inciso, l’Autore sarebbe perfettamente attrezzato alla bisogna. Osservatore attento della vita politica come è; e, in particolare, in grado di seguire il percorso intrecciato del partito comunista e dello stesso Napolitano “dall’interno”: che si tratti dei fatti di via Medina, delle tensioni, personali e politiche, che percorrono, nel corso del tempo, la federazione napoletana e della vera e propria guerra di successione degli anni ottanta e novanta, all’indomani della morte di Berlinguer.
Pure il suo testo è pieno di assenze; di false piste e di allusioni. A cominciare dalla scelta, incomprensibile anche perché non motivata, di passare sotto silenzio gli anni della presidenza – un passaggio conclusivo che sarebbe di per sé in grado di illuminare le tappe precedenti del percorso politico del leader napoletano. E questo, si badi, in un volume edito nella primavera del 2013.
In questa assenza voluta, l’indicazione contenuta nel titolo sembra buttata lì per portarci fuori strada. Perché, per un lettore superficiale e disattento, L’ultimo dei comunisti, con l’aggiunta del sottotitolo “la presa del potere,” hanno un significato preciso; e guarda caso in totale contrasto con la realtà delle cose.
Così “l’ultimo dei” suggerisce irresistibilmente razze in via d’estinzione (“i mohicani”) o combattenti irriducibili, e un po’ ottusi, di cause e di guerre già irrimediabilmente perse (“l’ultima raffica di Salò”; i soldati giapponesi abbandonati in una giungla fuori dal mondo). Mentre la presa del potere ha a che fare, da Luigi XIV a Napoleone a Lenin, con una iniziativa personale, volontaria e premeditata di rottura dell’ordine costituito, con annesso uso della forza.
Fantasmagorie. Pure e semplici fantasmagorie che sembrano alimentate da un illusionista o, più esattamente, da uno scrittore di romanzi gialli classici che semina il suo racconto di falsi indizi pur inserendo, qua e là, degli elementi suscettibili di guidare il nostro percorso verso la verità.
In realtà, Chessa questi elementi ce li fornisce in abbondanza. Ma senza mai illuminare il percorso con qualche analisi complessiva. Dal suo punto di vista, una rinuncia; che evidentemente non ha a che fare con i suoi rapporti con suoi potenziali lettori, ma piuttosto con le persone e le cose che sono la materia concreta della sua trattazione.
Avanziamo, a questo riguardo, una ipotesi; interamente frutto della nostra sensazione. Ci sembra di avvertire nel nostro Autore una totale mancanza di empatia nei confronti di un mondo che pure conosce assai bene; mancanza di empatia o antipatia preconcetta che dal soggetto collettivo – il Pci – si estende, per proprietà transitiva, al suo esponente; fosse pure, come nel nostro caso, il più qualificato. Napolitano, insomma, sarà anche il primo della classe (per inciso, con tutte le antipatie che alimenta questa categoria…); ma è la classe che, in qualche modo, non va; e quindi anche il suo migliore rappresentante.
Tutto ciò premesso sarà ora il caso di lavorare sugli indizi che pure Chessa ci offre; assumendoci, come si dice, l’intera paternità dei nostri ragionamenti e delle nostre conclusioni.
Primo indizio e punto di partenza, un nome. Che non appartiene, così ci suggerisce l’A., alla sequenza Marx-Engels-Lenin-Stalin, perché è quello di Machiavelli. Insomma, del cultore appassionato dell’autonomia e della razionalità della politica. E’ in nome di tali principi che Napolitano aderisce ad un partito che rappresenta sé stesso come moderno principe e che basa la sua diversità proprio sulla capacità di interpretare razionalmente il mondo in cui vive.
Ma Chessa ci dà anche un altro importante suggerimento. Ricordandoci che il partito cui Napolitano aderisce, nella stesso orizzonte di razionalità, è il partito nuovo di Togliatti. Un partito che, come quello francese, viene da lontano e vuole andare lontano. Insomma, dove i riferimenti ai percorsi del passato contengono in sé quelli di là da venire.
Si tratta però di riferimenti diversi. Perché, se i comunisti francesi sono eredi e, insieme, punto d’arrivo della tradizione rivoluzionaria, compito dei comunisti italiani è semmai la sostituzione della borghesia nella prospettiva di costruzione della nazione. Al di là delle Alpi, una vocazione classista e agitatoria (nel senso più neutro e pieno del termine); al di qua una vocazione unificante e, per certi versi, pedagogica. E, continuando a sintetizzare e a radicalizzare al massimo i fattori di diversità, a Parigi, il mito di Robespierre, della Comune e del popolo in armi; a Roma, quello di De Sanctis e di Gramsci.
C’è, in tutto questo, una evidente forzatura; che serve però a definire, e costantemente, nel tempo, l’approccio di Napolitano. Perché il suo orizzonte culturale e politico sarà, appunto, dal dopoguerra sino ad oggi, quello di un partito costruito nella prospettiva del razionale e del possibile (e dunque sicuramente un partito gradualista, anche se non necessariamente socialdemocratico; ci torneremo); ma anche caratterizzato da un fortissimo richiamo alla responsabilità nazionale, con le conseguenze che ne deriveranno, nel corso del tempo.
Una linea, e un atteggiamento, che saranno alla base delle diverse e contraddittorie fortune del leader napoletano e dei suoi amici: punto di riferimento naturale nei rapporti con il mondo esterno, con le responsabilità istituzionali che di volta in volta ne deriveranno e, al tempo stesso, considerati “altra cosa” nell’immaginario collettivo del popolo comunista; in auge fino a quando permarrà vivo l’insegnamento di Togliatti (e quindi anche all’epoca dell’allineamento con Mosca), fortemente emarginati in epoche successive quando, dopo la caduta del muro di Berlino i comunisti cercheranno in maniera affannosa nuovi elementi su cui costruire la propria diversità.
In questo quadro, il punto di svolta è agli inizi degli anni ottanta. Prima di allora il leader del gruppo (poi bollato come migliorista), Giorgio Amendola, conciliava in sé il richiamo disciplinare e identitario all’Unione sovietica con un forte impulso riformista e revisionista a livello nazionale. Era la famosa doppiezza che rappresentava però, in sé, un elemento di forza; perché, in definitiva, era proprio la sicurezza sulla propria identità e sul proprio futuro (l’Urss, il socialismo, la rivoluzione) che consentiva ai comunisti italiani la massima duttilità e apertura nella gestione del proprio presente. Era, insomma, la teoria staliniana che garantiva la pratica socialdemocratica; era la via italiana, anzi emiliana, al socialismo.
Dopo le cose si complicheranno. Per le ragioni e attraverso le vicende della “guerra di successione”che abbiamo già citata e che l’A. descrive alla perfezione. Una guerra, per il potere ma, ancora di più, per l’anima del partito che i miglioristi perderanno nettamente e definitivamente.
E per il combinato disposto di una serie di motivi.
In primo luogo perché i loro avversari si collocano su posizioni inattaccabili. Nella gestione di un partito che ha ricostruito la sua identità su di un nuovo tipo di doppiezza: la questione morale come garanzia della propria diversità di ultima istanza; a coprire una disponibilità senza limiti sul terreno del confronto economico-sociale. In soldoni, era l’asse Scalfari/Berlinguer; ma senza Berlinguer. Un asse che garantiva al Pci/Pds un salvacondotto di superiorità etica, di valore inestimabile nel clima dell’epoca; a vantaggio di chi e di che cosa essendo questione controversa ma tutto sommato irrilevante.
Un’identità sostitutiva, quella proposta dal nuovo gruppo dirigente; al posto della razionalità storica la sensibilità contingente. Pure, la loro scommessa risulterà vincente; per mancanza di alternative credibili.
Si dirà, nelle polemiche successive degli amici di Napolitano, che la linea alternativa, e abbandonata dal gruppo dirigente, era stata quella della socialdemocrazia. Una verità parziale; e auto consolatoria la loro. Perché se era vero che la nuova leadership si era costruita sul rifiuto della socialdemocrazia come retaggio del passato, era anche vero che questa prospettiva non fu affatto proposta. Né allora né dopo.
Attenzione: dicendo socialdemocrazia ci riferiamo non alla parola ma alla cosa. Insomma alla trasformazione del Pci in un vero e proprio partito del lavoro, capace di mediare costruttivamente tra Lama e Cofferati, aggiornando i propri strumenti di intervento ( a partire dallo stato) per garantire la conservazione delle proprie conquiste. Una socialdemocrazia riformista, insomma; se vogliamo l’unica possibile traduzione concreta del “migliorismo”.
Ma, come ci suggerisce, ancora, Chessa, i miglioristi, quelli in cane e ossa, alla socialdemocrazia non pensano affatto. Così da sbagliare, nel momento decisivo, insieme, avversari ed alleati.
In realtà il loro orizzonte vero non sta nel consolidamento socialdemocratico, ma piuttosto nel revisionismo socialista. Quello incarnato da Craxi (il cui governo, sia detto per inciso, di riforme ne farà assai poche…). Nell’immediato, una scelta suicida, perché coraggiosa fino alla temerità. In prospettiva, una scelta perdente perché organicamente subalterna.
Pochi cenni sul primo punto; anche perché oggetto di continue rivisitazioni. Per ricordare che qualsiasi ipotesi di intesa con Craxi e i socialisti era, per il suo proponente, un vero e proprio bacio della morte. L’uomo era odiato per quello che era e per quello che diceva; e i postcomunisti su questo avevano costruito la loro identità; essendo alla vigilia di riscuoterne i vantaggi con la caduta del loro nemico/concorrente. E senza pagare alcun dazio.
Il fatto è che, con il crollo del Psi, è la trincea socialdemocratica ad essere precipitosamente, e definitivamente, abbandonata; all’interno del Pds/Pd, come altrove; se mai fosse stata veramente eretta. A prevalere sarà invece la logica revisionista; incerta sui suoi obbiettivi quanto precisa sulle posizioni che intendeva emarginare. Tra queste, in primo piano, quelle appartenenti alla tradizione comunista; ivi comprese quelle riformiste. Così, dopo il decesso (per abbandono dei suoi stessi proponenti) della cosa 2, i rappresentanti di quella tradizione si ritireranno dal confronto politico interno: Macaluso e Cervetti per affidare a una rivista le “ragioni del socialismo”; Napolitano per diventare non già “l’ultimo comunista” ma piuttosto il primo, o comunque il più importante tra “papi esterni” cui il Pd ha delegato la gestione delle proprie fortune se non la rappresentanza della propria identità. Sempre con il consenso, più o meno passivo, degli ex miglioristi che degli interventi dei sullodati “papi esterni”sembrano avere costante bisogno.
Ma, tornando a Napolitano, forse Chessa ha ragione. Nel senso che le vicende, passate e attuali della sua presidenza appartengono a un’altra storia e a un altro libro; fatto salvo il suo diritto di prelazione nella trattazione della vicenda.
Titolo: L'ultimo comunista
Autore: Pasquale Chessa
Editore: Chiarelettere
Pagine: 256
Prezzo: 13,90 €
Anno di pubblicazione: 2013






